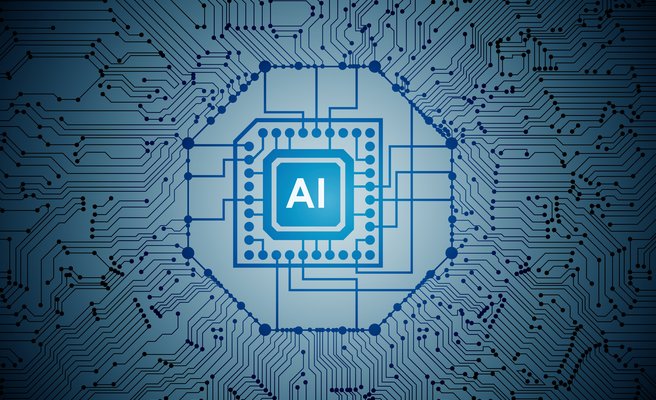È cominciato tutto con il crescente benessere dell’Europa postbellica, quando la bistecca della cena dopo il lavoro era uno status symbol che indicava che ci si poteva permettere la carne anche più di una sola volta alla settimana. Con l’introduzione degli allevamenti intensivi e della produzione industriale di alimenti, la carne e tanti altri generi alimentari, anche importati da Paesi lontani, diventarono sempre più accessibili. A metà degli anni Sessanta anche il negozio all’angolo proponeva cibi esotici: arance, avocado, gamberetti.
Allora eravamo tutti cosmopoliti, moderni e aperti – e avevamo il congelatore. Le verdure locali, sempre uguali, e i piatti stagionali appartenevano al passato. Le massaie non erano più costrette a trascorrere ore in cucina, e la maggior parte delle donne lavorava fuori casa, come gli uomini. Cucinare doveva essere veloce e pratico. I piatti pronti conobbero un vero e proprio boom, mentre la cena precotta da gustare davanti alla TV diventò di moda. La produzione di carne subì una crescita vertiginosa in tutto il mondo, passando da 84 milioni di tonnellate nel 1965 a 330 milioni nel 2017.
Ora il pendolo torna a muoversi nella direzione opposta. Le conseguenze ambientali dell’elevato consumo di carne e dell’agricoltura industriale impongono un ripensamento. La carne compare sempre più raramente sulle nostre tavole, il cibo deve essere il più naturale, sostenibile e locale possibile. L’industria alimentare punta sul «functional food»: alimenti che non si limitano a saziare ma che sono anche sani. Si riscoprono le vecchie ricette senza carne – sformati di pasta, torte salate alle verdure, crostini ai funghi. E il buon vecchio brasato della domenica, che cuoce lentamente per ore nel forno mentre familiari e amici chiacchierano allegramente a tavola, sta vivendo un trionfale ritorno. Naturalmente, anche come arrosto vegetariano.